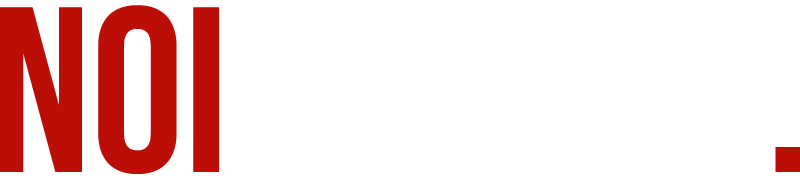Di Franco Presicci:
Sono nato alle tre Carrare. E’ in quel quartiere di Taranto che ho cominciato a strillare, mentre mia mamma mi cullava. Ero – diceva – il suo capolavoro. Poi arrivò mia sorella è il vero capolavoro fu lei. Di quella zona ricordo quasi tutto: le persone, le case abbattute per innalzarne di nuove; i giochi che facevamo da ragazzi, quando il marciapiede di fronte a casa mia era una sorta di piazza d’armi in terra battuta. Su quello slargo si apriva il tabacchino del signor Damiano, a cui qualche burlone aveva attribuito un soprannome che non si addiceva a quel signore anziano, un po’ burbero, ma buono, che, quando andavo a comperare le caramelle, mi domandava sempre come andassi a scuola e come fossero i miei insegnanti.
A quei tempi nelle vie irrompevano le voci degli ambulanti “’u cadaràre”, “’u conzagràste, un venditore speciale, che si presentava alle sette del mattino urlando “Uagnè’, le pampanèdde (formaggio fresco avvolto nella foglia di fico). E molte massaie gli andavano incontro con i soldi in mano. Squillavano anche le voci “d’u conzalùme” e “d’u ‘nghiappacàne c’u chiàppe e ‘a carrettèlle”. Se attorno a noi si aggirava un cane, appena vedevamo spuntare, dall’angolo con via Dante, il giustiziere con un gesto alla Silvan facevamo sparire il randagio.
D’inverno, quando impazzava il vento, i più impertinenti si divertivano con i vecchietti che andavano a comperare il “toscano”: legavano un filo bianco a un portafoglio disusato e stando nascosti
nell’androne di un palazzoo di fronte al negozio aspettavano. Quando la vittima vedeva il “tesoro” si piegava per prenderlo, quelli tiravano piano piano, costringendo l’anziano a seguirlo; e quando l’inganno veniva scoperto gli urli erano come gli ululati del lupo.
Ricordo un giorno in cui si doveva fare la fila per il sale davanti all’esercizio di don Damiano – se non ricordo male, mezzo chilo a testa – Un mio compagno di giochi, abituato a fare il furbo, acquistò il suo e poi s’intrufolò indossando un paio di occhiali scuri e un cappello simile a quello di un prete che va leggendo il breviario. Don Damiano chiuse un occhio ed evitò la reazione di chi osservava rigorosamente l’ordine.
Conoscevo molti degli abitanti vicini a casa mia. Compreso il poeta Diego Fedele, che aveva una decina d’anni più di me. Tra noi sorse una bella amicizia dopo un incontro fortuito in una salumeria. Di fianco al nostro palazzo c’era un ragazzo più giovane di me di cinque anni, Marino Ceci, dall’avvenire brillante: docente e dirigente scolastico, stimatissimo e amatissimo anche a Martina Franca e tra l’altro elemento prezioso di complessi musicali e virtuoso del pianoforte.
Ricordo quel signore anziano un po’ malaticcio“, che, seduto dietro a un banchettino davanti alle scuole “Thaon de Revel”, vendeva zuccherini in vasi di vetro e a richiesta raccontava la sua storia tormentata. “Non mi sposo, perché ho paura di mettere al mondo dei figli destinati a subire le conseguenze del mio stato”. Un personaggio indimenticabile era “’a Magenga”, una signora sempre pronta a correre quando uno aveva un foruncolo grosso come la pallina delle bottiglie di gazosa o una sbucciatura per una caduta o una piccola ferita. Ricordo una famiglia numerosa, madre di un paese vicino e papà ex milite come mille altri per ragioni di pancia, a cui era stato affisso il soprannome di “fascista”, ma era un uomo buono, noto per farsi sostituire nelle funzioni intime di marito. La malignità era dovuta al fatto che un amico era presente quando l’altro era assente. E si erano formate due fazioni fra colpevolisti e innocentisti molto ciarlieri, nonostante fossero fatti personali.
Due donne, che si affacciavano al balcone alle 5 del pomeriggio, alla vista di ogni passante stornellavano nomignoli. “Segaròne” era un signore grassottello e la puzza sotto il naso, un falso panama per nascondere la calvizie, sempre con un “siluro” fra le labbra non proprio come quello di Al Capone. “Guarda sta arrivando Sigarone! Chissà dove va così impupazzato”, paupulavano.
Avevo una quindicina d’anni quando a san Giuseppe e a Carnevale si accendeva il falò, alimentato da mobili vecchi, fascine, rami saccheggiati ad alberi incustoditi o rinsecchiti. E gli “architetti”
si impegnavano per fare la catasta più alta. Ci esaltava quel fuoco che crepitava schizzando faville. Nella via perpendicolare alla nostra erano alloggiati i vigili vigili urbani (di fianco c’era una cancellata). Più avanti, i pompieri. Alle nostre spalle la panetteria di “mest Petrìne”, dove la nonna mandava me o mio cugino Enzo con la teglia piena di taralli da infornare.
Ogni giorno il vecchio “zì’ Necòle”, spingendo il suo carretto con frutta e verdura, invitava le casalinghe ad acquistare. Era
generoso, affabile , comprensivo, serviva i clienti con sveltezza, lieto per l’affetto che gli dimostravano. “Eccolo, arriva, datti da fare, altrimenti se non vede nessuno lui passa avanti””, sentivo dire. Qualche volta vedevo passare il pianino con un uomo che, manovrando un congegno, faceva suonare una canzone, mentre il pappagallo beccava i fogli multicolori della fortuna.
“Ciccillo dalla mazza pronta (si favoleggiava della sua abitudine a minacciare la prole con il bastone) lavorava in arsenale e aveva in casa un grosso proiettore vantato come il cinematografo in salotto; e tutti aspiravano ad un invito che non arrivava mai. Per quanto riguarda la sua tendenza all’uso del bastone e della carota, era una malignità. Le comari del balcone definivano la moglie “Càpe ‘na còste”, perchè camminava con la testa leggermente inclinata da un lato.
Ero piccolo quando nell’androne dello stabile vicino aveva la falegnameria “mèst Fiorènze”. La sera non chiudeva mai il portone: i suoi attrezzi erano al sicuro, perché la categoria dei ladri non era ancora nata o era poco numerosa. Avevo un amico che abitava al piano terra, con la camera da letto fornita di una loggetta che dava sulla strada. Si chiamava Pierino Lincesso, e con lui ogni tanto conversavo, passeggiando. Non l’ho più visto. Ho ritrovato invece dopo anni Marino Ceci, che ascolto mentre suona il pianoforte nei video che posta su facebook. Lo segue anche Teresa Gentile, che ha un salotto letterario a Martina Franca quasi come quello della contessa Maffei a Milano e coltiva il talento di artisti in erba o già fioriti. Marino aveva un sogno, e credo l’abbia ancora: scrivere una colonna sonora per un film. C’è qualche regista che mi legge?

In quell’occasione conobbi Joe Sentieri e Vittorio Gassman, che alloggiavano al Park Hotel, in viale Virgilio. Del “cast” faceva parte anche Rosario Borelli, che anni dopo incontrai a Milano, seduto al tavolo del Bar Haiti di corso Vittorio Emanuele. Mi invitò a bere un caffè e si lamentò di essere stato assunto dalla casa cinematografica, che non lo faceva lavorare, forse perché puntava su Maurizio Arena.
Ho altri ricordi della mia Taranto di quei tempi: il monte delle vacche, dove i ragazzi andavano a giocare al pallone; piazza Marconi, dove aveva un chiosco il bravissimo attore Enzo Valli, al secolo Enzo Murgolo, con il papà brigadiere dei vigili urbani e attore a sua volta. Quella piazza nelle feste importanti ospitava l’albero della cuccagna. Ricordo anche “mèsta Rònze, ca vennèv’a gnète”; “ù ciucciarijdde ca facève ggerà a ‘ngègne” nel fondo del signor Capone; il direttore Suglia della scuola Acanfora e il bidello Antonio; la moglie del carrozzaio, che a gran voce chiamavano contessa, facendola inalberare.
E le leggende, presentate come realtà per ignoranza o per malafede: quella di uno sconosciuto con mantello nero e berretto dello stesso colore, alla maniera dei briganti, che compariva a mezzanotte in un punto isolato per salassare gli eventuali passanti. Non era la “mano nera”, come si voleva far credere, come quella che stava a New York ai tempi del solerte poliziotto Joe Petrosino. Quell’uomo in nero era per me soltanto frutto della fantasia di qualche burlone, che sosteneva anche di aver sentito l’urlo del lupomannaro e addirittura di averlo visto, sia pure da lontano.
C’era anche chi raccontava nelle sere d’inverno di aver partecipato a sedute spiritiche e di esserne rimasto traumatizzato la notte in cui il tavolo si sollevò e ricadendo si azzoppò. “Che notte! Scappando qualcuno capitombolò sulle scale”.
Tante storie, da inzeppare un volume. Come quelle dell’”’aùre” e “d’u munacìedde”. Una volta, sbirciando, ho visto giocare a “patrùn’e ssòtte”: il “sotto” proponeva un nome per un bicchiere di vino e l’altro rispondeva di no, accompagnando il rifiuto con ingiurie e beffe, trasformando il candidato in vittima e il preferito in ubriaco. Fortunatamente questo “processo” , che ha ispirato un libro di Roger Vaillant e un film, non è più di moda, almeno credo.
Tantissimi anni dopo sono tornato nella mia via del cuore. Ma non c’era più nessuno di quelli di una volta. Era piena di auto, un solo negozio di alimentari; la gente con il passo frettoloso come quello dei milanesi. Ci sono ore in cui la via è deserta, mi riferisce Carmine La Fratta, bravissimo fotografo viaggiante e scopritore di gemme. Anche le città e i paesi cambiano. Perchè cambia l’uomo.
Franco Presicci