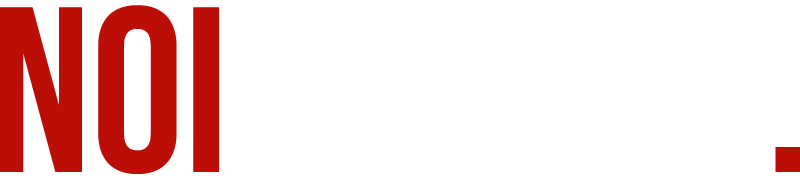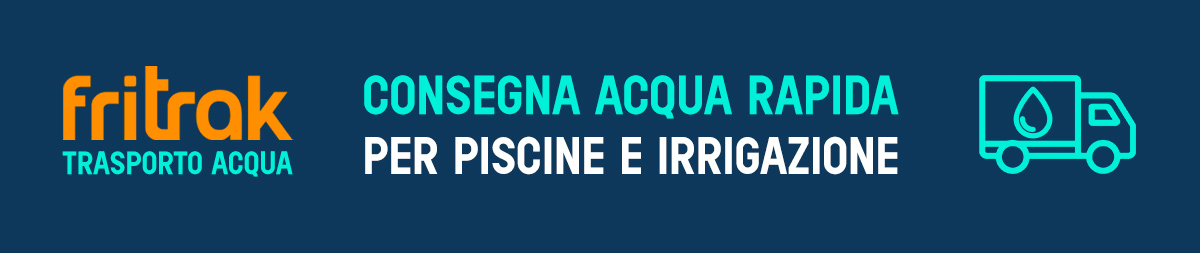Di Franco Presicci:
E anche il Carnevale è passato. Coriandoli, stelle filanti, maschere, carri addobbati… tutto portato via da un colpo di vento. Dei vecchi Carnevali, quelli che risalgono alla mia adolescenza, cioè un’ottantina di anni fa, io ho un ricordo vivido. Oggi i fotografi viaggiano da un capo all’altro del Paese per riprendere le feste in piazza con maestose figure allegoriche su quattro ruote, uomini, donne, bambini in maschera che suonano trombette di latta o di cartone, danzano, cantano o si esibiscono in giochi, scherzi ingenui a volte meno…

Ricordo il Carnevale del fegatino di Crispiano, che aspirava al posto di quello di Viareggio, mentre piogge di cerchietti multicolori cadevano “nazzecanne” dai balconi imbandierati con lenzuola e tappeti. Ai miei tempi il Carnevale era modesto, forse perché erano gli anni della miseria e la fantasia non bastava. Ma i falò erano giganteschi. Si animavano vere e proprie competizioni: chi li faceva più alti era osannato. Qualcuno sistemava sulla cima il carnevale defunto con le prefiche improvvisate affrante, straziate per il dolore finto. A fare sempre più grandioso il falò erano i cittadini, che gettavano sulla strada le carabattole che occupavano soltanto spazio, e i “comò”, le “colonnette”, gli armadi divorati dai tarli; qualche altro procurava le fascine, che il carbonaio di via Dalò Alfieri non aveva; qualche altro aveva acquistato i fiammiferi dal tabacchino di don Damiano e il falò prendeva fuoco, scoppiettando, arrostendo il povero carnevale di pezza, che aveva fatto divertire grandi e piccini, ballare nelle case specialmente con le canzoni napoletane: ad esempio “”I’ te vurria vasà|…”, di Vincenzo Russo, figlio di un calzolaio e di un’operaia; e quelli nati negli sfarzosi “Caffè Tripoli” “Gambrinus”, dove Gabriele d’Annunzio, seduto ad una tavolo, scrisse “A vucchelle”.
Il Carnevale come oggi era allegria, spensieratezza, invenzione. Tutti si esaltavano. Non c’erano gli abiti di Zorro o del pirata Barbanera, che furoreggiò nel Mare dei Caraibi, e molti si arrangiavano magari vestendosi da donna con il seno gonfiato da due arance e la capigliatura confezionata in qualche maniera e i tacchi fatti di legno nudo o di un materiale trasparente. Bastava poco per fare scena. L’importante era partecipare alla festa.

Il carnevale porta gioia. E a Milano, dove dura tre giorni di più, quando scompaiono i coriandoli e le stelle filanti la gente torna a correre come alla maratona dei cinquantamila. E allora c’è chi dice: “Corri, corri, ma dove vai?”. Le ragazze in bicicletta della nota canzone lo sanno che devono inebriarsi del sole in fronte; il compianto fotografo-ciclista Benvenuto Messia, della splendida Martina Franca, sapeva che stando in sella con il vento in faccia poteva avere l’occasione di uno scatto di quelli che non si ripetono. Ma a Milano corrono tutti, anche i nuovi meneghini, e quando chiedi a qualcuno: “Perchè corri?” non sa neppure lui la risposta. C’è chi non rinuncia a correre nemmeno a carnevale e nei cortei arriva con i pattini o con il monopattino, di quelli moderni dotati di motorino. Non come i nostri 80 anni fa: ce li facevano da noi, con le ruote dei cuscinetti dei camion americani. Ma ai cortei di carnevale andavamo a piedi, sensibili al grido del venditore di arachidi e lupini.
A Milano ci andavo per scrivere le cronache. E ammiravo Meneghin e Cecca e le zabette della Pucci, una brava attrice che le accoglieva in una sala di Radio Meneghina di Tullio Barbato. Erano simpatiche, le zabette, ma se le stuzzicavi reagivano. Una volta mi sostituì una collega che le definì come non doveva: pettegole e vecchiette, ma le zabette non erano né vecchie né pettegole. Anzi alcune erano anche attraenti. Per riparare andai a far loro visita, rimanendo per due ore al microfono con la Pucci, raccontando barzellette. L’anno dopo ripresi a raccontare il Carnevale, che a volte veniva disturbato da alcuni scavezzacolli che lanciavano oggetti pericolosi e fu proprio Tullio Barbato a richiamarli all’ordine, perché il carnevale è una festa e tale doveva rimanere.
Non ho mai visto il carnevale di Venezia, se non nelle pagine dei libri di Fulvio Roiter e nelle foto di Carmine La Fratta, sempre attento a cogliere il momento, la luce giusta, le espressioni. Quando, nell’85, per lavoro andai a Venezia (dovevo intervistare il questore Mario Iovine), vidi in piazza San Marco, prima di salire sul motoscafo della polizia, solo chioschi ricchi di piccolissime maschere in gesso. Ne comperai un paio, barbute, che conservo ancora.

A Carnevale è lecito impazzire, purché non si faccia male a nessuno. Una volta , e forse ancora oggi da qualche parte, il Carnevale fatto di stoffa o di altra materia veniva appeso ai balconi o tra una ringhiera e l’altra. Povero Carnevale! Prima impiccato e poi defunto. Eppure è portatore di buonumore, di letizia.
Rileggo qualche riga di Giacinto Peluso, che va oltre nel tempo: quando “per noi il carnevale s’identificava con un personaggio che ogni anno faceva la sua apparizione nel vico Statte e vi sostava, riverito e stimato, sino al Martedì grasso. Era un grosso pupazzo alla cui confezione partecipavano un po’ tutti, chi con il materiale, chi con la mano d’opera. Si costruiva un “omone, imbottendo di paglia un enorme pantalone e relativa giacca. Poi si sagomava la testa, di solito rotonda, la si conficcava in un manico di scopa che a sua volta s’infilava nel corpo del manufatto. Sul volto si appiccicava una maschera comprata nel negozio di Gaeta vicino alla chiesa di San Michele”.
Questo è’ solo un brano estrapolato da un lungo capitolo di “Taranto da un ponte all’altro”, ricco di dettagli, come è solito fare Peluso, studioso di grande qualità. Di fianco al testo campeggia una foto del carnevale del 1893.
Anche i poeti hanno scritto versi sul Carnevale, tra questi appunto Diego Marturano, a cui ha dato brillantemente voce Amelia Ressa, che a suo volta scrive poesie. Fate pure i funerali al pupazzo, tanto l’anno venturo rinasce. E perdonate se questo mio pezzo vi appare un po’ disordinato.
(foto: Egidio Ippolito e Mimino della Biblioteca)