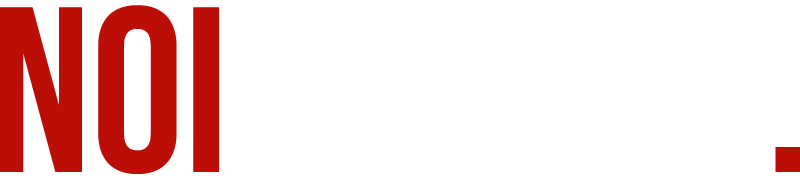Di Franco Presicci:
Parlare con lui era piacevole, ma anche edificante. Rispolverava episodi, situazioni, personaggi, senza mai farei nomi. Non per nascondere. “Una volta che la gente ha pagato il suo debito non deve finire sempre alla ribalta dei giornali con la carta d’identità in bella vista. Legittimo raccontare i fatti, soprattutto se sono stati curiosi, clamorosi, impressionanti, ma l’autore ha già scontato la sua pena, magari lavora, i figli vanno a scuola, la moglie è una persona per bene, la gente ha dimenticato, quindi è bene che vada lasciato in pace”. E tutti quelli che avevano lavorato con lui (Vito Plantone, Mario Jovine…), nelle interviste applicavano la sua regola.
Prima che un grande poliziotto Mario Nardone era un grande uomo. Quando conversavo con i suoi collaboratori emergeva sempre la sua figura. In questura nessuno aveva cancellato Nardone dalla memoria: il “mito” o il “gatto”, per il suo fiuto“. Ci metteva poco a intuire chi c’era dietro una rapina o un omicidio e imboccava la via giusta per cercarlo. Era un indagatore solitario e silenzioso. Quando apprendeva una notizia, rimaneva un attimo a meditare, poi via. Tutti si chiedevano dove andasse e lo sapevano quando tornava con il carniere occupato. Quando Vito Plantone, già questore di fresca nomina, parlava di lui, se non lo nominava sembrava si riferisse a Poirot o a Maigret, anche se Nardone non aveva niente in comune con questi assi della letteratura gialla. Lui era Nardone e basta. E aveva ricordi chiari e precisi.
Lo intervistai per la prima volta a Como, dove era questore, dopo essere stato capo della Squadra Mobile a Milano (inventata da lui). Quando andò in pensione mi ricevette in casa sua, in via Tortona. Mi preparò personalmente il caffè, perchè la moglie era fuori, e mentre sorbivamo la bibita, anticipava le domande. Allora aveva 70 anni. E già molti assi della letteratura e del giornalismo, tra cui Nantas Salvalaggio, lo avevano spremuto. Era senplice, estroverso, spontaneo. E molto amato. Cominciò col dire che “quando ho parlato con una persona ho parlato con centomila. Non è mai venuto fuori l’identità di chi ha collaborato con me: ho rispettato il suo segreto. L’umanità era per me la norma”. La moglie di un detenuto si ammalò gravemente, una malattia misteriosa e Nardone si dette da fare, l’aiutò e la donna guarì. Rispettava la mala e la mala rispettava lui. “Ho buone doti, è vero; ma anche difetti. Per esempio, mi arrabbio a freddo. Alla squadra Mobile facevo di quelle sfuriate! Ma dopo dieci minuti mi sbollivo e invitavo la persona che avevo trattato male a bere un caffè”.
A Milano arrivò nel ‘48. Aveva 31 anni. Vice-commissario aggiunto. Il papà era questore e quando lui gli comunicò il suo desiderio di entrare nella polizia gli rispose: “Se ti aspetti che ti raccomandi stai fresco”. “Anche papà aveva tanta umanità, ma era più duro di uno spartano”. Nel capoluogo lombardo Nardone bruciò le tappe. Capo della Mobile e poi della Criminapol. Seguì casi fragorosi. Il delitto di via San Gregorio, per esempio; la rapina di via Osoppo; l’arresto in una villa sul Lago Maggiore del Paesanino, noto come il “Giuliano del Nord”, che con il suo luogotenente, il “Brambillino”, entrambi contadini ignoranti, avvolti nel mantello nero dei briganti della Bassa, venivano in moto a Milano, compivano rapine e rientravano. Nardone individò il covo del Paesanino e spacciandosi per idrauico vi fece irruzione mentre il bandito russava. Si era servito delle cicale della malandra, che gli avevano dato indicazioni molto vaghe, ma lui, indagando, la individuò e con i marescialli Valente e Navarra mise fine alla carriera del…brigante.
Poi mi raccontò la storia della banda del semaforo rosso. Era il ‘58 e quattro grossi personaggi della malavita romana tenevano sotto tiro molti rappresentanti di gioielli, che “alleggerivano” con il sistema della gomma a terra. Ogni volta gli investigatori trovavamo una moto Guzzi di grossa cilindrata targata Roma, che risultava appartenere a un detenuto nella Capitale. Il proprietario del mezzo affermava di non saperne niente. E ogni due o tre mesi i rappresentanti, dopo aver visitato i clienti, si accorgavano di avere una gomma dell’auto afflosciata; e mentre si accingevano a manovrare il clic la valigetta con i preziosi spariva. E poi si trovava la moto. Ed ecco l’intuito del felino: “intuii che la moto veniva spedita per ferrovia, feci appostare alcuni poliziotti e quando questi mi avvertirono che delle persone si aggiravano attorno alla Guzzi li feci portare in questura e li torchiai. I banditi venivano in treno e dopo il colpo partivano in aereo. Il detenuto conosceva bene l’uso che della sua moto veniva fatto”. La banda operò dal ‘56 al ‘58. In quel tempo le consorterie di rapinatori erano tante e le rapine che realizzavano lasciavano la città sbigottita. Per esempio, l’assalto all’oreficeria Colombo in peno centro talmente ben congegnata che un giornale del pomeriggio, “Il Corriere Lombardo”, la ricostruì con tutti i particolari. “Dei miei uomini – aggiunse Nardone – ho avuto sempre grandissima stima. E infatti erano uomini di grosso spessore, come il maresciallo Ferdinando Oscuri, abituato come lui a passare le notti in questura.
Nardone interrogava fino alle 4 del mattino e alle 8 era nuovamente seduto alla sua scrivania. Era una persona sensibile. Una sera che con alcuni suoi “detectives” andò a fare una perquisizione domiciliare raccomandò ai suoi uomini di fare piano per non svegliare i bambini (lui ne aveva due, oggi uno mdico e uno bancario).
“Dalla polizia ho avuto grandi soddisfazioni. Mi hanno mandato in Vietnam, in Cambogia, in Giappone, a New York, dove m volevano ma non sapevo l’inglese. Se dovessi tornare indietro, rifarei tutto quello che ho fatto”. Quando un’indagine si presentava difficile, alzava gli occhi al cielo e diceva: Aiutami, papà!”. Per la cronaca, il capo della Mobile Zamparelli, dopo un’operazione brillante andava a pregare nella chiesa di Santa Rita.
La signora Nardone diceva che il lavoro del marito era per lei un nemico: la costringeva a lunghe attese e preoccupazioni. Ma il “Gatto” non mollava la preda: mandò al “gabbio” decine di assassini, circa 400 falsari e non so più quanti di quelli che avevano le mani sporche di droga e tanti “duristi” (rapinatori determinati e decisi a tutto); fece vestire da prete un poliziotto, andò in Brasile con il maresciallo Oscuri per acciuffare uno della banda di via Osoppo; si finse magliaro, cantò una canzone napoletana per ammaliare un rapinatore fuori di testa.
Nardone raccontava senza enfasi e senza orpelli: non aveva bisogno di montare come la panna le sue storie per renderle più avventurose ed esaltanti; e chi gli stava di fronte assorbiva ogni sua parola. Su lui si alimentavano leggende. Ogni sua azione finiva sui giornali. Una volta lo sottrassero assieme al suo vice, Mario Iovine, alla celebrazione di un matrimonio. Se li portò via una volante perché era in corso una rapina. Soprattutto i settimanali pubblicarono a puntate la vita e le imprese di Mario Nardone. Più recentemente la televisione nazionale gli ha dedicato uno sceneggiato di molte puntate.
Il giorno dei funerali i giovani cronisti, soprattutto quelli delle antenne private, assediarono i colleghi più anziani facendo valanghe di domande: “E’ vero che lo soprannominavamo il Gatto”. “Perchè?”. “Quando arrivò a Milano?”… mentre il corteo si allungava, si allargava, comprendendo quasi tutta la questura. Nardone era stato un esempio, aveva fatto scuola. Max Monti, vecchia volpe de “Il Corriere della Sera”, si appostò sotto una finestra per catturare qualche brano dell’interrogatorio di Rina Fort, non pensando che Mario Nardone non era tipo da farsi sorprendere. Riferii questo episodio a una collega di “Telenova”, e lei avida di notizie continuava a bombardarmi. L’accontentavo perché era un’ottima collega, che purtroppo ho perso di vista. Neppure oggi Mario Nardone viene dimenticato. Fino a poco prima della morte, se prendeva un taxi, l’autista lo riconosceva e gli sorrideva, chiedendogli: “Come va, signor Nardone?”. Nei ristoranti c’era sempre chi si alzava e lo salutava. Tutti sapevano che era stato sempre in prima linea nella lotta contro la criminalità. Aveva in mente nomi, cognomi, nomignoli, indirizzi, tecniche, caratteri dei maggiori esponenti della malandra. Domandai a Vito Plantone, quando era questore di Catanzaro, un giudizio su quel “detective” basso, magro, un po’ calvo. Mi rispose: “Era un poliziotto nato”.